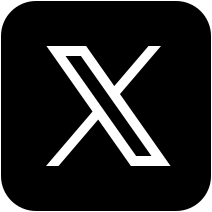Fabio Zuffanti – new album – Hjarta – recensione e full streaming
Bruno Martino cantava “Odio l’estate”. Non ho mai chiesto nulla a Fabio Zuffanti circa le sue preferenze stagionali, quindi non so se la pensi come Martino, però, ascoltata la sua ultima fatica Hjarta, sono convinto che potrebbe affermare senza esitazione “Amo l’inverno”. Non so se sia la stessa cosa, però non si pensi ad una polarità stagionale opposta, se non addirittura oppositiva: l’inverno sonoro di Zuffanti è una stagione dell’anima che ha, a suo modo, un calore per nulla festaiolo e, meno che mai, natalizio. È un inverno naturale, protetto da un gelo, messo lì a conservare un cuore lasciato nel profondo. In islandese “cuore” si dice, appunto, “hjarta” e l’Islanda, come un po’ tutte le isole, sa abbandonare le nozioni di un banale libro di geografia di seconda media per farsi metafora esistenziale: anche l’Islanda usa i suoi ghiacci per tenere a bada – quasi con amore – quel fuoco geotermico in arrivo dalle viscere telluriche.
Così, a 5 anni dall’ottima prova di In/Out (e a 13 dall’indimenticabile La foce del ladrone), Zuffanti – tra un libro e un live con La Maschera di Cera – trova pure il tempo per dare alle stampe un nuovo disco. Liquido, poiché fruibile solo sulla piattaforma Bandcamp. Ora non si pensi sia una sorta di raccolta di briciole dimenticate nel cassetto: un album quasi autarchico, con pochi coinvolgimenti personali ma di notevole qualità. Non è un lavoro buttato giù di corsa, nato da un’impellenza protagonistica. Semmai, se d’impellenza vogliamo parlare, essa è squisitamente artistica, creativa e comunicativa (ha qualcosa da dire).
Versi ermetici e un demiurgo affidabile, Matteo Ricci, tecnico del suono dello Studio 77, nonché chitarrista dei Malombra. Costui ha dato una grossa mano a Fabio stendendo gli arrangiamenti, curando la regia sonora e suonando quasi tutti gli strumenti, compresa la batteria su espressa richiesta di Zuffanti (“Volevo che fosse suonata da un non-batterista”). In aggiunta Agostino Macor, amico e compagno di mille avventure con Finisterre e La Maschera di Cera. Tre in studio per un’opera di sincero e marcato ecclettismo, con un piccolo sguardo al passato, quando Fabio Zuffanti si cimentava nelle primissime prove soliste tra le mura di casa e qualche saletta. Alcuni marcatori invernali c’erano già lì e, via via, sono cresciuti (Pioggia e luce, Ghiaccio e Gennaio senza luce come Quadraphonic): con Hjarta arriviamo al completamento di un quadro vivace, in quanto quel disegno preparatorio, ormai, si è fatto icona precisa di un immaginario simbolico a lungo cercato, ispezionato e testato.
Lo dicono anche i versi dei testi (sussurrati nel canto, come Anima Latina insegna): la difficoltà dei rapporti umani al cospetto di plurimi “tu” montaliani (in Neve all’alba il ghiaccio che “tiene” diventa correlativo oggettivo), figure brillanti (il sangue che si porta in spalla le tenebre in Pozzo nella notte mi ha riportato alla memoria la luna ormistica di La fabbricante d’angeli che “si ferisce passando i vetri rotti”), immagini leopardiane (sempre nella stessa canzone, il pozzo che “riflette il coltello della notte” rimanda al clima notturno in Le ricordanze, così come le “grandi stelle” di Nuova terra) e temi scomodi (il velato riferimento al suicidio in Morire di pioggia).
Se vogliamo possiamo leggere il disco come un concept visto che Zuffanti mi ha raccontato di avere scritto le liriche in una sorta di stream of consciousness, ispirato dalla musica: il plot è la storia di due esseri umani, uno in difficoltà e l’altro pronto a dare una mano, e delle loro dinamiche esistenziali.
Un cuore poetico che sta proprio in quel titolo: Hjarta si chiama anche una poesia di Tomaso Labranca, scrittore scomparso nel 2016, con cui Zuffanti condivideva affinità artistiche e una sincera amicizia, oltre a svariati progetti.
Partiamo dagli elementi di base: Fabio Zuffanti propone 6 tracce, sostanzialmente 5 canzoni e un brano strumentale. Le canzoni hanno in comune una struttura armonica essenziale, semplice e diretta: spesso la melodia è costruita su due accordi che si alternano su linee elementari. Soffermiamoci un attimo su due aggettivi: semplice ed elementare. In questo caso la semplicità è l’altra faccia di una complessità da ricercare altrove (ci arriviamo tra un po’); “elementare”, invece, fa riferimento all’oggettistica narrativa della canzone che, come tale, racconta per sprazzi e illuminazioni secondo una prosa lirica ermetica, scarna, se non addirittura scabra. C’è poco da dire, ma tanto da evocare. Zuffanti non ha mai ambito ad essere “cantante”, al limite potrebbe piacergli sentirsi “cantore”, ma è (anche) un cantautore.
E poi questa voce, dove la mettiamo? “Sotto”, in salamoia, così si conserva meglio. Il Battisti di Anima latina avrebbe detto “sotto acetato” e Zuffanti non esita a lasciarla sullo sfondo, perché sia parte della musica che pervade ogni territorio, senza essere, però, invasiva.
Equilibrio nella forma e nella sostanza; a tal proposito l’aggiustamento percussivo – anche questo figlio di un settore di Anima Latina (Abbracciala abbracciali abbracciati) – punta in quella direzione: fare suonare la batteria al chitarrista (nonché tecnico del suono e co-produttore) del disco, ovvero Matteo Ricci. Ci voleva uno che non solo sapesse tenere le bacchette in mano, ma che pure “vedere” la dinamica complice, quella giusta per l’opera in crescita; dare forma a quel settore sonoro, oltre la mera scrittura di eventuali pattern.
Ciò spiega anche perché Zuffanti si sia rivolto ad un gruppo veramente ristretto: oltre a lui e a Ricci, il tastierista Agostino Macor a spennellare con i sintetizzatori e varie tastiere (un ottimo lavoro di tessitura: sono spazi di colori tenui in un album “bianco”).
Quando la minima sfumatura diventa un dettaglio in primo piano senza alcuna prepotenza: il disco è tutto un susseguirsi di particolari che appaiono e scompaiono, come in un cortometraggio sperimentale dai piani sequenza lunghi e lenti.
Un accenno alla chitarra di Ricci: nell’allure di Hjarta, riverbero e delay la fanno da padroni, ma il dettato storico è variegatissimo perché se, spesso, pensiamo ad Hackett, talvolta certe dilatazioni timbriche rimandano al sound di Fripp in Heroes o di David Rhodes in L’imboscata, senza trascurare citazioni dal mondo post-rock e shoegaze.
Per i riferimenti stilistici, basta entrare in punta di piedi nella playlist e lasciarsi sfiorare da consonanze di svariata estrazione: l’opener A Different House comincia con un sibilo da cui emerge un sequencer d’organo alla Terry Riley e alcuni sinistri accordi pieni, parenti del Battiato di Fetus e Pollution; poi l’armonia procede e avvicina il brano ai Genesis sinfonici di The Lamb Lies Down on Broadway con una ritmica floydiana.
Per Neve all’alba siamo al cospetto di una sorta di impressionismo musicale sotto zero con la neve che cade in forma di arpeggi, armonici e notine acute in un crescendo indolente, ma che accumula timbri su timbri fino ad una chiosa sommatoria: ormai siamo travolti da una bufera di suoni dissonanti.
Pozzo nella notte, invece, si inserisce in un filone più tradizionale, nel senso che qui Zuffanti sembra confrontarsi con l’aspetto più cupo della canzone d’autore italiana degli anni Settanta: senza toccare i due caposaldi inamovibili (Battiato e Battisti), in questo brano si avvertono affinità con il Faust’o di Funerale a Praga.
Dominio simile quello di Morire di pioggia, in cui quel retroterra storico-musicale si assimila ad una ricerca di frontiera che va dal post-punk (Joy Division) ai Radiohead, passando per Peter Hammill. Ma Morire di pioggia è una canzone strana, proprio sul piano della scrittura. Provo a spiegarmi: fosse stata più veloce, avrebbe messo in mostra un’armonia foriera di una ballad pop dagli sviluppi orecchiabili. Non è stato, però, così, per un paradosso: ha un testo che si arricchisce per sottrazione, quindi la musica chiedeva di essere diluita e stemperata, attraverso un metronomo bradicardico e un set timbrico minimale.
Nuova terra ritorna sulla dissonanza come figura espressiva, giocata su sovrapposizioni tonali che si aprono ad interferenze provenienti da altri spettri sonori: tutto si muove su una scala discendente, costellata qua e là da piccoli cromatismi che spuntano come afasici asterischi (ma suonano). Coordinate stilistiche? Siamo tra le chitarre grezze dei Marlene Kuntz, il mellotron di Strawberry Fields Forever e i sintetizzatori analogici dei corrieri cosmici tedeschi.
A proposito di mellotron e di scale discendenti: è da lì che bisogna approcciarsi nella conclusiva Hjarta. Un prolisso strumentale che si basa su una cellula armonica di otto battute (Mi minore, Mi minore/Re, Mi minore/Do, Si maggiore, La minore, Mi minore, Do maggiore e Si maggiore). Se non fosse per la tonalità diversa, le prime quattro battute ricordano Genesis Ch.1. V.32 di Alan Parsons Project (stessa scala discendente e stessi intervalli, ma un tono sotto – Re minore). Al di là di questa derivazione, Zuffanti utilizza il plot per dare spazio ai diversi timbri della sua “orchestra” per definire in maniera sempre più nitida l’affresco: il mellotron, la chitarra che arpeggia (1’34”), il piano elettrico (2’02”), il mellotron/flauti (2’03”), un campione di violoncello (3’04”), una melodia al piano elettrico (3’30”), il tema portante ripreso dalla chitarra (4’02”) e ripetuto due volte con la sovrapposizione di quella del piano elettrico (4’34”), solo basso e batteria (5’06”) con ripresa della chitarra (5’22”), quindi ingresso di una seconda chitarra (5’38”), aumentano i rumori di feedback e distorsioni (6’42”), ripresa del tema iniziale per chitarra (7’14”), pedale di basso e mellotron / coro (7’46”), inserimento di un sintetizzatore e ritorno della chitarra (8’18”), falso finale del mellotron (9’27”) e rumori in fade-out con accenno all’armonia iniziale ormai frantumata in polvere di note (9’37”). Quasi un tema con variazioni timbriche come in un congedo a passacaglia che lentamente si consuma.
articolo originale sul blog dell’autore