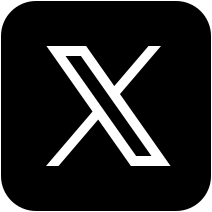Steven Wilson – The Future Bites – 2021 – (Caroline) – recensione e guida all’ascolto
Steven Wilson resta uno di quei compositori da tenere d’occhio perché, quando “fa”, ha veramente qualcosa da esprimere. Più che un musicista, lo definirei un esploratore di stili, aperto e privo di qualsiasi pregiudizio. Oddio, l’affermazione può sembrare un po’ iperbolica, ma è ovvio che non si voglia diminuire o sottovalutare la sua prioritaria capacità compositiva perché lui, molto banalmente, si occupa di suoni ma non lo fa mai in maniera banale. Tutto sempre felicemente discutibile, talvolta generando divisione tra fan di ieri e di oggi (ma è sempre bene superare la cortina degli ultras).
Non mi riferisco solo all’apprendistato con i Porcupine Tree ma anche alle innumerevoli produzioni soliste, alle collaborazioni e, non ultime, alle rimasterizzazioni di grandi classici del progressive rock, con un Wilson abilissimo tecnico alla console. La storia è nota (ma chi ne volesse sapere di più, rimando al recente volume di Del Longo – Parri – Salvi per Tsunami e alla retrospettiva scritta da Fabio Zuffanti su Rolling Stone).
Che cos’è The Future Bites? Ben più di un semplice disco, non solo un concept album, ma una visione nemmeno del tutto distopica di un presente che diventa futuro – minuto dopo minuto – a causa soprattutto delle reti (quasi neuronali), vettori di qualsiasi comunicazione, azzerando spazio e tempo in un unicum disorientante e disorientato. Wilson racconta l’apocalisse del presente e lo fa a 360° utilizzando anche i mezzi messi sotto la lente dei testi, della musica e, non ultimo, di un poderoso apparato multimediale. Questo spiega il ricco corredo di video, allegato all’opera, che aiutano ad entrare meglio nella narrazione (li trovate in fondo al pezzo).
Insomma, finalmente c’è qualcuno – nel mondo della musica – che ci racconta la complessità del reale in modo diretto, con passione e, al tempo stesso, anodino distacco. Una trasfigurazione in ipercinetico divenire (camaleontica e caleidoscopica). Dick incontra Orwell, ma tresca di nascosto con Luther Blisset. Non più fantascienza, ma una fanta(sia) – scienza social(e).
Wilson non lavora all’ordito da due giorni: aveva cominciato a seminare indizi già da marzo 2020, sotto forma di singoli, fino all’uscita integrale avvenuta lo scorso 29 gennaio. Ci aveva preparati e, complice il chiuso pandemico, ci aveva deliziato con alcune preziose session pubblicate sempre su Youtube.
The Future Bites consta di 9 tracce, una quarantina di minuti di canzoni. La qualità è sempre alta e basata su una ricetta solida e onesta: Wilson dà forma alle sue idee e, mai come questa volta, l’elemento “atmosferico”, “climatico” del suono, nella sua matericità (ben oltre la materialità), ha prevalso su qualsiasi ritocco che possa mettere in evidenza uno strumento, piuttosto di un altro. Wilson è un buon chitarrista e un raffinato tastierista, sempre perché sono gli altri a dirlo; in effetti ha gusto, ma non è un virtuoso e lui stesso sa di usare gli strumenti come il pittore utilizza i colori della tavolozza. E, alla fine, ti ritrovi, senza quasi volerlo, di fronte ad un affresco. Questo l’effetto provato al cospetto di The Future Bites. Però, piano: è presto per urlare al capolavoro, nonostante la pressante tentazione.
Vale la pena soffermarci e scendere nel dettaglio: lo farò la prossima settimana con l’analisi del disco traccia per traccia.
Ah, detto tra noi, se il 2021 è partito così, come inizio non c’è male (alla faccia di chi sostiene che non esista più la buona musica).
Date le premesse e inquadrato il personaggio, non ci resta che immergerci nei suoni e, laddove sia possibile, nei testi. Eccovi un tentativo di guida all’ascolto del disco.
Unself – Un’apertura che arriva dal rumore indistinto di un cupo fruscio da cui emergono due accordi di chitarra acustica, un piano e la voce di Wilson assai riverberata; c’è lo zampino di un ricevitore ad onde corte. “All hail to love/ And love is hell” recitano le parole, perché, in fondo, “il sé ama solo se stesso” insomma, lasciate ogni speranza voi che ascoltate.
Self – Appunto, il “sé”, ovvero la dimensione individuale e individualistica che sembra ormai permeare ogni attività umana, per di più amplificata al massimo dal fiato energetico delle comunicazioni multimediali. Lo sappiamo bene come lo slang anglofono “selfie” abbia ormai soppiantato l’impomatato latineggiante “status”, ma la sostanza non cambia se, dietro ad ogni manifestazione di sé stessi, si celino strategie (spesso meschine) finalizzate al raggiungimento del potere (grande o piccolo che sia). “Self-absorbed and self-obsessed”: come rendere in musica questa dimensione? Wilson riprende in mano tutto l’armamentario pop anni Ottanta, quello ricco di stile e dal significante ritmico inconfondibile. Ci sono i giri di basso e chitarra da hit alla Peter Gabriel, i sequencer dei Depeche Mode, le scorie elettro-rock degli Inxs e i cori dei Tears for Fears. È musica di consumo che consuma e racconta coscienze consumate: la metamorfosi da uomo a cliente del sistema è quasi completa. Piccolo cameo per l’ex Porcupine Tree (e Japan) Richard Barbieri ai sintetizzatori.
King Ghost – Il trattamento elettronico pop qui raggiunge una rifinitura integrale: tastiere elettroniche e panneggi raffinati, un po’ come quelli degli Art of Noise più sofisticati (chi ricorda il magnificente concept The Seduction of Claude Debussy del 1999). Il sequencer si muove con i colori di un’arpa campionata, la ritmica è affidata a due batteristi “essenziali” (Jason Cooper dei Cure e Michael Spearman degli Everything Everything). Addirittura più intrigante il lavoro che Wilson fa sulla voce: un falsetto alla Mango che diventa strumento aggiunto a tutti gli effetti; di lì si dipana un ritornello dalla melodia netta e precisa che ben si adatta ad un controcanto più grave.
Quel sé così “selfish”, da “re fantasma” quale è, domina totalmente la personalità dell’essere umano, al quale, disperato, non gli resta che supplicare: ” Mi aiuterai a raccogliere i miei pensieri? Mi aiuterai a trovare le transizioni che ho dimenticato?”
12 Things I Forgot – Il tema dell’identità smarrita e dimenticata offre a Wilson l’occasione per regalarci una ballata nel suo stile. La critica ha abbinato la canzone ad alcuni frutti del passato (si sono citate Lazarus dei Porcupine Tree e Happiness III del 2016). L’attacco iniziale di chitarra acustica mi ha ricordato vagamente quello della notissima Show Me the Way di Peter Frampton; le frasi di pianoforte intingono il brano di una vernice pop cara ai Muse. L’armonia funziona, così come la melodia e il ritornello, solare come mai si era sentito da queste parti. Un piccolo capolavoro: tutti i suoni risultano pertinenti, nulla risulta mai fuori posto o sopra le righe. Una misura che tocca ogni strumento, al di là delle suggestioni esterne: la chitarra acustica è il motore di tutto; il piano “parla poco” ma lo si memorizza subito; e poi c’è una bella elettrica (4’10”) che sigilla l’epilogo con un eco caldo quasi valvolare, un po’ come se fosse uscito da un disco degli Shadows.
Eminent Sleaze – Tutto gira intorno ad un territorio tonale fisso per un esperimento musicale ben radicato nella musica nera: un basso “duro” e sporco (Power Station?), così come il pianoforte che, di tanto in tanto, viene fuori; i violini alla Philly Sound sono suonati dalla London Session Orchestra; l’altro piano – quello elettrico, un Fender Rhodes – svisa da padrone. Certo: è tutto soul ad ampio raggio partendo da Isaac Hayes per arrivare a Prince, ma attenti sempre al canto: la linea canora ha un richiamo distopico-sonoro alle distorsioni vocali di Lake in 21st Century Schizoid Man e anche l’irregolare solo di chitarra punta verso un universo frippiano. Non diamo mai nulla per scontato con Wilson e accogliamo qualunque suggestione (anche quando meno ce lo aspettiano).
Man of the People – Una ballad alla Gilmour con la drum machine? L’eredità floydiana – che fu dei Porcupine Tree – continua a maturare. Può essere, ma non fermiamoci alle (pur solide) apparenze: il brano coglie il suo placet soprattutto per il lavoro sulle armonie e le timbriche vocali. Wilson riprende quanto già sperimentato in King Ghost ma all’interno di uno spettro espressivo addirittura più vario. Il testo parla di una persona pubblica coinvolta in uno scandalo che ha messo a nudo debolezze e nefandezze, tutto sempre sotto l’occhio vigile del villaggio globale dove ogni traccia non si può cancellare (“E cosa resta di noi? Adesso ci sono solo le ceneri. L’ambizione mi ha congelate, come un inverno demoniaco”).
Personal Shopper – L’attacco al consumismo è servito e quale miglior corredo musicale se non quello estraibile da codici sonori, appunto, di consumo? L’uomo si è incarnato (e incarnito) nell’anima del cliente (altri tempi, quando, invece, la pubblicità era l’anima del commercio). In realtà alla fine, resta solo un lungo elenco di prodotti: l’uomo ha perso anima e corpo, perché il futuro morde e ci fagocita, spersonalizzandoci dentro e fuori.
La scelta di Wilson è coraggiosa: oltre 9 minuti per un pezzo dalla scorza techno, ma che non rinuncia ad accumulare elementi stilistici eterogenei (un po’ come quei prodotti gettati alla rinfusa nella borsa della spesa). Il tema portante è una sorta di Dies Irae, suonato all’inizio dalle note basse di un sintetizzatore: strano l’effetto di sentire nella stessa massa sonora reminiscenze kraftwerkiane e flebili lucori argentini di piani elettrici quasi jazz-rock. Tutto suona “strano” ma non certamente estraneo a chi sa ascoltare: una struttura ballabile degna del Giorgio Moroder più danzereccio, delimitata da un ritornello (“Buy for comfort, buy for kicks”) molto anni Ottanta (Human League? Inxs?) ed un bridge (“Consumer of life, hold my hand, extend your rights…”) tra gli Abba e gli Asia.
In mezzo è tutto un gioco di dinamiche dosate e mai forzate, quasi come se fosse un movimento sinfonico, con tanto di “interludio” adagio, cadenzato da una lista della spesa declamata da Elton John come se fosse una litania.
Follower – L’altra ossessione è quella del “follow”, la caccia all’attenzione altrui per manifestarsi come si vorrebbe essere e non si è. ” Mi muovo dentro di te come una febbre per farti credere quello che voglio… Io sarò il mattone virtuale attraverso la tua finestra”: la persuasione del sistema in un mutante Truman Show egoico. Wilson dà forza ai suoi versi avvalendosi di una spinta rockatronica sgorgata da reminiscenze anni Ottanta: c’è Billy Idol, un po’ di Sigue Sigue Spuntnik, qualche schizzo di Devo; ma un ritornello aereo ci riporta indietro addirittura agli Yes di una Siberian Khatru macchiata di noise post-rock.
Count of Unease – Chiusura in tono (apparentemente) minore con un’altalenante lullaby in cui Wilson suona tutti gli strumenti: è un congedo quasi in sordina, come se il protagonista di questa storia (allucinante e presente) si fosse liberato di ogni scoria (per niente è la “conta del disagio”). In realtà siamo di fronte ad un dissolvimento, un annichilimento e al completamento narrativo di un quadro, alla fine, pessimistico. Sul versante musicale, prevale un camerismo elettronico affidato ai sintetizzatori e agli effetti riverberati delle chitarre e del pianoforte.
E in fondo ci siamo arrivati. Che dire? Un album coraggioso, che, sicuramente, continuerà a dividere i “follower” di Wilson, ma basterebbe veramente liberare qualche incrostazione pregiudiziale a cui siamo affezionati (le etichette) per apprezzare questo lavoro in tutta la sua essenza.
Articolo originale alla pagina https://scrittoreprogressivo.wordpress.com/2021/02/21/steven-wilson-the-future-bites-caroline-international-2021-guida-allascolto-ii-ii/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfiMjLyNWxeZKDdgnx0HJR_vqUyXM5Q19