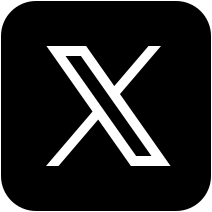Incontri con la classica vol.3: Ritratto di Aaron Copland
Fotografia di copertina di Erich Auerbach | Getty Images 1965
Aaron Copland. Ricordo la prima volta che lo sentii nominare. Lì per lì lo confusi con Stewart Copeland; erano i primi anni Ottanta e sapevo assai di “Novecento storico”, però i Police erano già nella mia playlist.
Ma il nome di Copland arrivava, comunque, sempre dal rock: Emerson Lake and Palmer… The Fanfare for the Common Man: pensavo fosse loro, invece era di un compositore americano; uno che aveva scritto per il balletto (mi venne raccontato). Approccio superficiale, il mio: ero molto più attento a quegli ultimi scampoli di prog che Emo e i suoi ci aveva lasciato, prima che la band si sciogliesse. Io arrivai a Works 2, quando gli E.L. & P. già non esistevano più. E il mio rapporto con Copland finì lì.
Passa qualche anno e, nel mio viaggio a ritroso tra i dischi del trio, mi imbatto di nuovo in lui: tutta colpa di Trilogy dove scorgo Hoedown tratto dal balletto Rodeo. Brano scoppiettante, pieno di vita fino all’eccesso.
Questo Copland mi sfizia non poco e, durante varie ricerche, un altro reperto interseca il mio cammino: Copland non è solo un compositore ma anche un intelligente divulgatore, tanto che il suo Come ascoltare alla musica resta una delle più stimolanti letture per chi voglia capire cosa frulli nelle nostre orecchie, quando entrano delle note.
Era arrivato il momento di conoscerlo meglio, così mi procurai qualche disco.
Da tutti è considerato uno dei pionieri della musica classica americana; a differenza di Gershwin, Copland è più legato ad una certa tradizione accademica e meno al jazz (benché non manchino, qua e là, spunti tratti da quella cultura sonora): probabilmente il suo maggiore merito va individuato nel modo in cui sia riuscito ad innestare pezzi della tradizione musicale popolare americana su un tessuto “accademico”, la cui influenza più significativa resta quella di Stravinsky.
L’America bianca è presente nel già citato Rodeo, ma anche in Billy the Kid, nelle danze di Appalachian Spring, nonché nelle tre sinfonie; ma i confini si allargano al Messico (El salón Mexico) e ai Caraibi (Danzón cubano per pianoforte). Nonostante l’apprendistato europeo (per la precisione francese, con Nadia Boulanger), il carattere della musica di Copland permane squisitamente americano, radicato nello stesso melting pot continentale e ricco di colorazioni timbriche cangianti e inedite per il mondo del repertorio classico. Ecco, sì: alla fine, Copland, a suo modo, è “classico”, come lo erano Mozart e Haydn; mi riferisco al rigore della forma che sa tenere a bada qualsiasi euforia dinamica o scritture melodiche di ampio respiro, prossime al blues o alla folk song. Anche lui, in quel Novecento storico poco letto dalle fazioni ideologiche: Copland non era uno stravinskiano convinto, ma solo un musicista che seppe trarre dal russo l’approccio misurato alla stesura dello spartito; così come seppe rinnovare e ravvivare non poche intuizioni coloristiche mediate dall’impressionismo musicale transalpino. Tutto questo, in America, in riva ai grattacieli e alla modernità.
by Riccardo Storti (blogger musicale e fondatore del Centro studi per il Progressive Italiano)
articolo originale a questo link