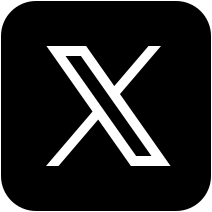Recensione pietra miliare: Banco del Mutuo Soccorso – Banco del Mutuo Soccorso – 1972
Il salvadanaio. Abbiamo tutti imparato a chiamarlo così: originale il Banco del Mutuo Soccorso, già dalla copertina del disco.
L’originalità va avanti, buttando subito un occhio alla struttura della band: due tastieristi e per di più fratelli. Non si era mai vista una roba del genere. E al Foro Italico di Roma se ne era accorto il pubblico, presente al II Festival di musica d’avanguardia e di nuove tendenze (in rete c’è la performance lanciata in diretta da Renzo Arbore). Erano i primi di giugno del 1972 e, da circa un mese, i ragazzi avevano esordito proprio con il mitico “salvadanaio”.
Si diceva della line-up: sulla plancia di comando delle armonie i due fratelli Gianni e Vittorio Nocenzi danno vita a tutto l’apparato contrappuntistico ordito intorno all’impianto strumentale del gruppo: Il più giovane, Gianni Nocenzi, è il pianista virtuoso, quello che meglio sa condensare una notevole esperienza (benché non abbia ancora compiuto 20 anni), maturata tra spartiti che vanno dal romanticismo alle avanguardie del Novecento, senza trascurare quel minimo di jazz che “fa”. Vittorio Nocenzi, invece, si “limita” a colorare di timbri cangianti l’idea orchestrale delle composizioni: per ora si ingegna solo con l’organo Hammond (ma da Darwin! in poi arriveranno i sintetizzatori) e, in quanto a fantasia, sinceramente non ha eguali nel panorama italiano: il suo è un lavoro di tessitura che deve inventare di volta in volta variegate sonorità a seconda dell’espressività compositiva e dell’interpretazione del collettivo; insomma: è il “maestro concertatore” di vecchia scuola.
Sul palco, un unico cantante, ma soprattutto un cantante unico, Francesco Di Giacomo: ha quanto si richieda ad un front-man di razza ovvero la presenza scenica e la voce. Corpulento, con la barba lunga: è l’immagine del Banco ricordata da tutti, anche dai fruitori di musica più distratti. Ma Di Giacomo offre al gruppo un valore aggiunto grazie alla scrittura: i suoi testi resteranno tra i migliori (se non i migliori) di tutta la produzione progressive italiana.
Già ce ne accorgiamo dal “salvadanaio”, in cui il contributo lirico è in compresenza con Vittorio Nocenzi: lo pseudo-Ariosto di In volo, l’inno antimilitarista di R.I.P. (Requiescant in pace), la sfiducia verso il genere umano di Metamorfosi e l’inquietante fiaba onirica de Il giardino del mago.
A completare l’ensemble, la sezione ritmica di Renato D’Angelo (basso) e Pierluigi Calderoni (batteria) e la chitarra di Marcello Todaro.
L’incipit ha qualcosa di veramente singolare: l’atmosfera sognante da Orlando Furioso di In volo lascia presto il passo al ritmo serrato (quasi hard rock) dalla dinamica detonante di R.I.P. (Requiescant in pace); ma quello che ascoltiamo è progressive a tutti gli effetti: ce lo sottolineano i metri composti, i concitati interventi solistici e i cambi di atmosfera. È sufficiente che si sia “seduto il vento” affinché il brano assuma quasi le caratteristiche di un’aria melodrammatica ottocentesca.
Superato il Passaggio (un tenue vocalizzo accompagnato dal clavicembalo), Metamorfosi ci aggredisce subito con le strette verticalizzazioni in 11/8 del riff su cui, piano piano, si arrampica ogni parte strumentale: più che l’anima, questa è la colonna vertebrale di una composizione articolata e mutevole per il gioco di atmosfere contrastanti. Qui c’è la testa per una musica che deve molto al repertorio colto ma in funzione di un rock in continuo mutamento (ecco dove sta la vera “metamorfosi”).
Il giardino del mago è di fatto la prima vera suite “consapevole” del progressive rock italiano: con i suoi oltre 18 minuti, il pezzo copre quasi tutto il lato B del disco (se si eccettua la breve chiusa di Traccia) e si palesa come una caleidoscopica composizione dalle ambiziose mire stilistiche. Con le sue quattro sezioni collegate tra loro, Il giardino del mago si sorregge inizialmente su un motivo melodico – dai tratti dissonanti – accennato dall’organo e poi, via via, ripreso da altri strumenti, fino allo sviluppo canoro operato da di Di Giacomo. Ampie cesure chiaroscurali sono garantite da due determinanti episodi: uno quasi barbarico (5’22”, anticipatore di certi sentori di Darwin!) e l’altro lirico e arioso (8’22”). Un caleidoscopio che mischia jazz, classica, folk e psichedelia fino ad una compenetrazione definitiva in cui ogni cellula si fa sintesi per la realizzazione di un organismo musicale completo.
(Riccardo Storti, articolo originale sul blog dell’autore)