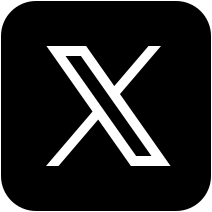Oliver Murray – Bill Wyman, the quiet one (documentary, BBC – 2019) – recensione
“Se vuoi sapere qualcosa che è ci è successo, devi chiedere a Bill” (Keith Richards)
Ora ho capito perché Bill Wyman non poteva essere assimilato all’ottima abbuffata di Vita da Rolling Stones, ma meritava un documentario a sé. E mi è bastato guardarlo quel “documentario” ovvero Bill Wyman. The Quiet One diretto da Oliver Murray e disponibile sulla piattaforma di RaiPlay (guardatelo, prima che lo tolgano).
Il suo è proprio un altro mondo che si è incidentato con la nascita, l’evoluzione, i successi e l’apoteosi dei Rolling Stones, di cui, però, non ne ha mai condiviso minimamente gli eccessi (in particolar modo quelli legati alla dipendenza da droga e alcol).
Una sola cosa interessava il buon Bill (oltre al gentil sesso): la musica. Unica stella polare della sua vita, contornata da altri addentellati creativi che toccano in particolar modo le arti visive. Appassionato di fotografia fin da ragazzino, crescendo ha sviluppato una sensibilità tale da avere sempre con sé una cinepresa e lì arriviamo all’archivio.
Sì, perché Bill Wyman è l’archivio vivente dei Rolling Stones e non solo. Ognuno di noi è “archivio” della propria vita, ma tale affermazione ha, per lo più, una valenza metaforica. Ebbene, per Wyman, essere archivi di sé stessi è soprattutto documentare concretamente al massimo la propria esistenza che, nel suo caso (come in quello di altri musicisti noti) coincide con un versante pubblico assai ampio, pertanto avere fatto parte degli Stones significa essere stato testimone di un fenomeno fondamentale nella storia del costume e della popular music mondiale.
Il carrello introduttivo, che apre il docufilm, ha qualcosa di impressionante: ci mostra da lontano Wyman seduto alla scrivania, mentre dà le spalle allo spettatore; lo vediamo spuntare nell’inquadratura dopo che la macchina da presa si è focalizzata con pazienza su file e file di scaffali zeppi di ogni tipo di materiale mnemonico: dalle agendine alle locandine, dalle macchine fotografiche ai registratori e poi cassette, bobine, rullini, negativi, fotografie. Una biblioteca di Babele.

Il ritratto che ne esce degli Stones è molto trasparente: Wyman spiega la sua uscita dal gruppo, avvenuta nel 1993, come un esito fisiologico, generato da altri interessi e da una semplice necessità: riprendersi la propria esistenza per viverla in una quotidianità modulata su passioni e naturali incombenze come vivere in famiglia, fare la spesa e chiacchierare con la gente.

Wyman è schivo ma non misantropo: riflessivo, mai freddo perché basta guardarlo negli occhi; non ha mai smaniato per mettersi in mostra, nemmeno come bassista, restando spesso in ombra. Eppure “faceva il suo” con una precisione e attenzione al dettaglio, guidato da un’onesta professionalità quasi artigianale, lui che era nato con il rock’n’roll ma aveva riscoperto il blues. A differenza degli altri Stones, era figlio della working class della periferia proletaria londinese, nato e cresciuto in una famiglia operaia numerosa (aveva 6 fratelli); la sua infanzia fu gravata da notevoli traumi (era un bambino quando Londra venne rasa al suolo dai bombardamenti aerei tedeschi del 1940-41). Chi l’avrebbe mai detto: è lui il primo ad esclamare ciò, tra un aneddoto e l’altro. Perché negli anni Cinquanta non era facile decidere di intraprendere una carriera musicale, così su due piedi (in una gloriosa nazione uscita, comunque, malconcia dal secondo conflitto mondiale). Poi il caso – ma fino a che punto? – lo fece diventare il bassista dei Rolling Stones.

Ma ci sono stati anche altri incontri, come quello con Marc Chagall, avvenuto in Francia nei primi anni Settanta: il pittore era già molto anziano e tra i due nacque una bella amicizia. E quello con Ray Charles, il suo idolo assoluto: Ray chiese a Bill di suonare nel nuovo disco in preparazione, ma il bassista si schernì e con timidezza rispose: “Non sono all’altezza”,
Articolo originale alla pagina https://scrittoreprog.blogspot.it/?view=sidebar