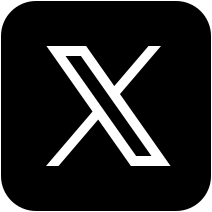Dave Murray – Vita da Rolling Stones (documentary, BBC/SKY – 2022) – recensione
Come raccontare la storia della più longeva rock band del pianeta? È la somma che fa il totale – diceva Totò – così ci si inventa una serie di 4 puntate, una per ogni componente storico, quasi ad offrire una visione più ampia possibile ma da angolazioni diverse: Mick, Keith, Ronnie e Charlie. Alla fine, invece, diamo ragione ad Aristotele: il totale è ben più della somma delle singole parti.
Per nulla agiografica, la serie Vita da Stones (reperibile su Sky Italia, titolo originale: My Life as a Rolling Stone – BBC) riesce ad attribuire ad ogni musicista una caratteristica organica al gruppo: Jagger e Richard come lo Yin e lo Yang (quindi non per forza amici, figuriamoci fratelli…), Ronnie il mediatore e Charlie l’apparente estraneo che, però, tutti ascoltavano come leader silenzioso nelle retrovie dei suoi tamburi.
Lo spaccato che ne esce è quello di una confessione studiata e concordata (nei minimi particolari), diremmo quasi da copione, perché quanto emerge è noto; più particolare – se non proprio “originale” – il modo che hanno i quattro di relazionarsi con la macchina da presa. Ormai sono signori di una certa età che ne hanno combinate di cotte e di crude, segnando – qua e là – dei sentieri ineludibili nell’evoluzione del rock, inteso come fenomeno sia sonoro sia sociale. Ognuno è quasi una maschera di compostezza britannica, all’interno di un quadro sempre “eccessivo”, perché la storia degli Stones visse d’arte, di eccessi e di rumorosissime litigate: oggi ci sono un Jagger vibrante sereno, un Keith saggio sornione (ma mai pentito di nulla), un Ronnie clownesco e un ricordo di Charlie. Sempre impassibile.
Nella narrazione, al di là della mitografia docufilmica, viene ben evidenziato il peso non solo cronologico della loro vicenda musicale: Mick Jagger resta l’instancabile performer che, ancora oggi, ad ottant’anni suonati, non molla sul versante di un perfezionismo interpretativo tale da non lasciare spazio a remore o sbavature. Quel “personaggio”, che calca le scene dal 1962, è ancora lì a chiedere copioni e coreografie da eseguire, fin che il tempo lo vorrà.
Keith Richards non è mai stato un virtuoso, ma un intelligente chitarrista che ha saputo piegare e forgiare lo strumento sulle sue attitudini ritmiche, trasformando le lacune in punti di forza: la serie scende nei dettagli tecnici e mostra la magia delle accordature aperte sulla Telecaster privata del Mi basso. E Keith te la racconta come l’idea più banale: it’s only rock’n’roll but I like it. E scomoda la parola “fratello”, quando parla di Ron Wood, subentrato a Mick Taylor nel 1975 e proveniente dai Faces di un altro Rod, Stewart.
Taylor era il bluesman professionista idoneo per assoli da paura, ma è con Wood che gli Stones hanno trovato un gemello chitarristico, dotato della stessa sensibilità (coloristica e ritmica) di Richards. La scelta più naturale, dopo che furono scomodati i nomi di Steve Marriott, Ray Cooder, Jeff Beck e Peter Frampton e provinati Andy Summers – futuro Police -, Harvey Mandel dei Canned Heat e il turnista Wayne Perkins. Una scelta che – a detta di Ron Wood – fece andare su tutte le furie Eric Clapton.
E poi c’è l’omaggio a Charlie Watts (scomparso nel 2021) che riapre la questione relativa alla sottovalutazione di certi batteristi nati e cresciuti musicalmente negli anni Sessanta. È toccato a molti (cito solo Ringo Starr) e non ne è stato esente Watts, tacciato a volte di essere un batterista limitato, troppo scarno, monotono, etc. Il documentario mostra invece come, dietro la semplicità e essenzialità dei suoi pattern, vi fosse una garanzia ritmica che, insieme alla chitarra di Richards e al timbro di Jagger, è di fatto uno dei marchi di fabbrica del sound Rolling Stones. D’altra parte lui si sentiva estraneo alla vita della band, allo stesso rock’n’roll, in quanto appassionato di jazz: se Richards stravedeva per Chuck Berry e Jagger per Johnny Lee Hooker, Watts ascoltava per ore e ore Charlie Parker. Poi, nella seconda metà degli anni Settanta, all’arrivo dei groove funky soul del Philly Sound, si fece traghettatore di questa sensibilità disco nel campo minato hard blues della band, rivoluzionandone l’itinerario stilistico (riascoltiamo I Miss You da Some Girls del 1978 con Ian MacLagan dei Faces al piano elettrico e Mel Collins al sax…). E sarà il jazz a salvargli la vita, quando, ormai quarantenne, proprio lui così impassibile e – apparentemente – controllato, diventerà dipendente dall’eroina; e dopo la disintossicazione inizierà quell’entusiasmante epopea con la Charlie Watts Orchestra.
In tutto ciò, stride il fatto che il bassista originario Bill Wyman (uscito dagli Stones nel 1993) venga citato assai raramente; sinceramente trovo questa una macchia tutt’altro che trascurabile, perché si tratta di un tassello importante nella ricostruzione dei primi 30 anni di carriera della band. Va detto però che Dave Murray, il regista di Vita da Rolling Stones, ha diretto anche The Quiet One, docufilm interamente dedicato alla figura di Bill Wyman (disponibile su RaiPlay).
La storia del gruppo si può condensare in una battuta di Keith Richards: “Gli assoli vanno e vengono, un riff è invece per sempre”… che detto dall’inventore di Satisfaction… Chapeau!
Articolo originale alla pagina https://scrittoreprog.blogspot.it/?view=sidebar