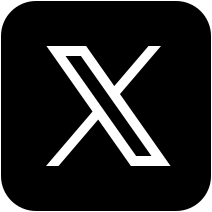Paul McCartney – III – 2020 – recensione
Covid-19 tutti in casa. Non c’è storia. E uno come Paul McCartney che fa? Ne approfitta per mettere un po’ d’ordine. Rovista nei cassetti e tira fuori lembi di canzoni appena abbozzate ma mai rifinite; riff e melodie in cerca di testo (perché l’autore ci sarebbe già). Potrebbe essere l’occasione buona. Uno studio domestico non gli manca; la palla autarchica di suonare e registrare ogni strumento, nemmeno. Poi, dato un occhio al calendario, il 2020 avrebbe festeggiato i 40 anni di McCartney II e i 50 di McCartney. Non c’è il due senza il tre, anche se questo vi impiega ben 5 lustri ad arrivare, ma mica è un problema. Così il nostro – con il tipico entusiasmo del ragazzino quasi ottuagenario – gioca e si diverte, senza l’assillo della doverosa commissione discografica. Nessuno con il fiato sul collo, nessuna scadenza di date sui palchi, nessuna fretta. Il baronetto ha dalla sua il tempo e l’ozio – anzi otium – di cazzeggiare, farsi demiurgo come non mai.
Ho ascoltato questo disco, prima di tutto, con affetto, senza aspettarmi particolari prodezze, ma, semmai, cercando di cogliere quanto di interessante possa (ancora) proporre Paul McCartney. I capolavori e le pietre miliari sono alle spalle, rifulgono in un museo universale e nessuno ne potrà mai mettere in dubbio gli input qualitativi innescati nel mondo della musica.
Oggi abbiamo un signore vicino agli ottant’anni che ha ancora voglia di raccontarsi. E lo fa con il solito canzoniere ottimistico che parla di spiritualità (Slidin’), amore per gli altri (Deep Deep Feeling e Seize the Day) e per il pianeta (Winter Bird/When Winter Comes), ma che non esita a richiamare un’attenzione più ampia verso l’attualità (la sovraesposizione mediatica di Pretty Boys e la necessità di speranza in Find My Way). Eppure McCartney trova spazio anche per passioni giovanili (Women and Wives, dedicata al bluesman Lead Belly), divertissment (The Kiss of Venus, song di ispirazione astronomica) e ricordi salaci (l’ironia graffiante di Lavatory Lil, un ritratto femminile senza censure: basta dare un’occhiata al video per capire…).
Quanto ai suoni, essi sono “da richiamo”, nel senso che rimandano ad atmosfere e plot già affrontati in molti album. Per chi conosce bene l’opus di McCartney, non è stato difficile cogliere taluni deja-vu: i ritmi pellerossa dell’opener Long Tailed Winter Bird portano alla memoria il clima di Kreen-Akrore, di Loup (1st Indian On The Moon) e di Tug of Peace; i riff aspri e duri di Slidin’ ricordano lo stesso entusiasmo di Oo You, mentre il fingerstyle di The Kiss of Venus ha il carattere di That Would Be Something e le aperture melodiche di Some People Never Know; Deep Down, invece, è un ritorno quasi ballabile alla stagione pop tra fine Settanta e anni Ottanta (le trombe sintetiche che scorrono petulanti da Back to the Egg a Press to Play).
Convincenti le ballate acustiche (Pretty Boys e Winter Bird/When Winter Comes), l’interpretazione blueseggiante di Women and Wives e quella più elettrica di Lavatory Lil; non potevano mancare reminiscenze beatlesiane negli staccati ad effetto di Seize the Day e nel ritornello di Find My Way. Una spanna sopra, il moto dilatatorio di Deep Deep Feeling: oltre 8 minuti di neo-psichedelia cangiante nei suoni e nella metrica: qui si sente che si è preso tutto il tempo per dosare i plurimi interventi vocali, liberare nastri magnetici, dare peso ad essenziali gravi note di pianoforte, rispolverare un mellotron, aprire squarci di luminose modulazioni e lavorare di cesello con un’adatta vernice gilmouriana su semplici (ma toccanti) frasi di chitarra. Una piccola suite tutta “made in McCartney factory” che non deve scomodare alcuna etichetta (so già a quale genere stiate pensando, ma non cado nel tranello).
Articolo originale su ScrittoreProgressivo